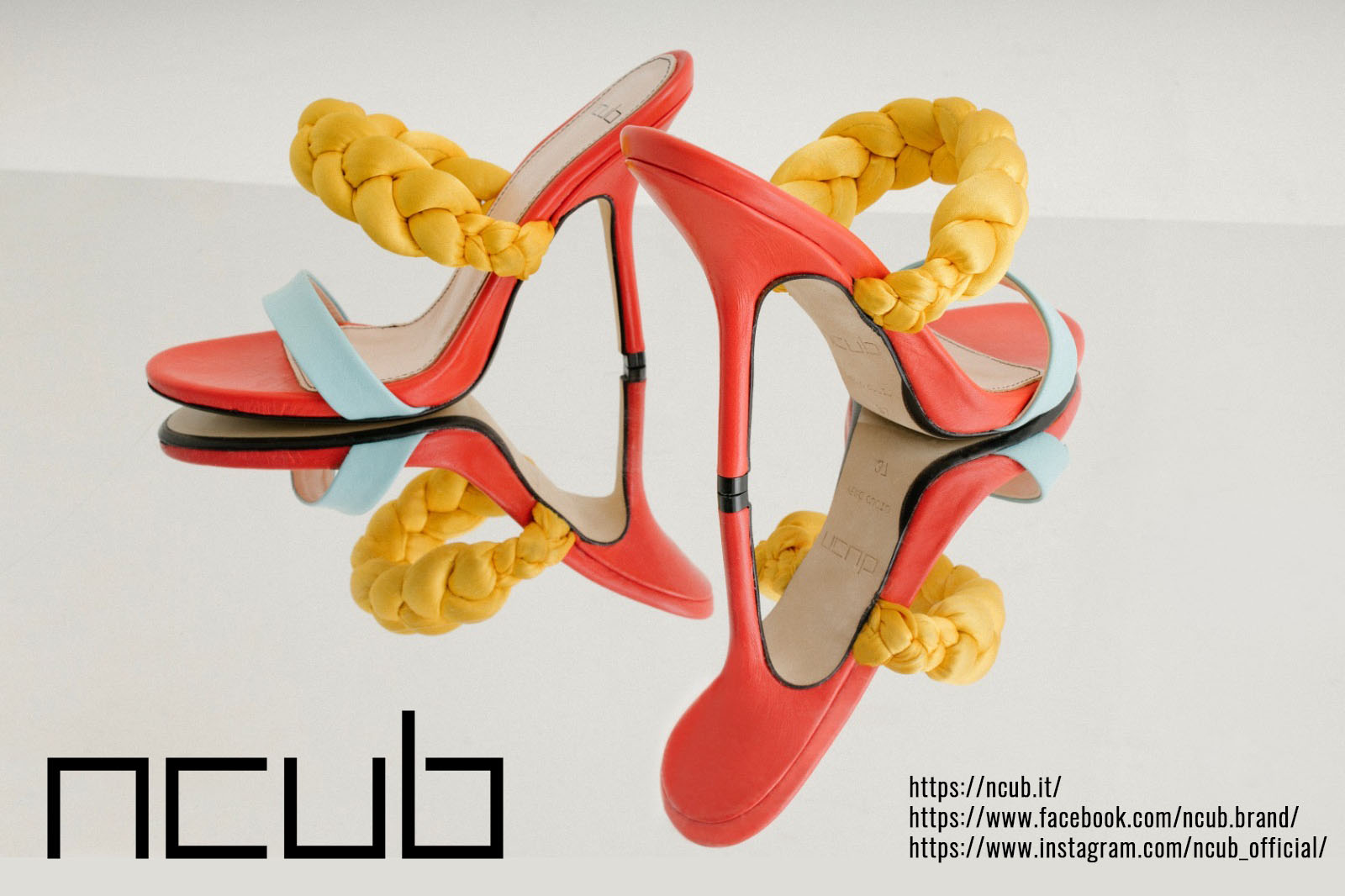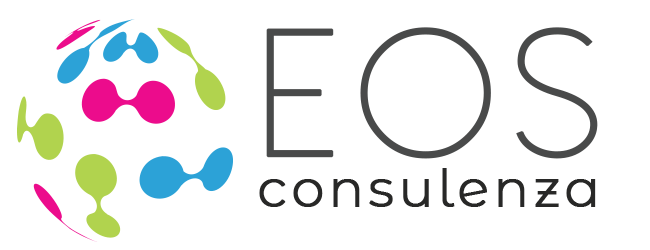Il realismo della pace. De Gasperi e la radici della Comunità Europea di Difesa
Share
di Riccardo Saccenti
«Noto solo ora che il cardi. T.[isserant] quindici giorni fa mi raccontò avergli Pio XII assicurato che fra tre quattro giorni forse vi sarebbe la pace, e ciò poco prima che Chamberlain reagisse negativamente assieme a Daladier contro il discorso pseudopacifista di Hitler. Il card. rispose, agitato, che prima della pace viene la giustizia». Questa annotazione sul diario di Alcide De Gasperi, disponibile in una preziosa edizione curata da Marialuisa Sergio, risale al 25 ottobre 1939. L’invasione della Polonia da parte delle divisioni hitleriane ha innescato il precipitare dell’Europa e del mondo nel conflitto mondiale e l’allora bibliotecario della Vaticana fissa tutta la tragicità del momento. Soprattutto, dalle pur succinte frasi citate, emerge con chiarezza la consapevolezza di come quella che si consuma sui campi di battaglia in Polonia e poco dopo sul fronte occidentale sia una lacerazione dell’ordine internazionale, le cui radici profonde vanno ricercate sul terreno culturale e, per così dire, spirituale delle nazioni europee.
I lunghi anni trascorsi da “esule” in Vaticano, pur tra sofferenze e umiliazioni personali, avevano offerto a De Gasperi la possibilità di ripensare in profondità le ragioni e la forma dell’agire politico, prendendo in considerazione il valore essenziale del rapporto fra la dinamica civile e politica interna e il quadro più ampio dei rapporti fra stati e nazioni. È una consapevolezza che si palesa, ad esempio, nel carteggio con Stefano Jacini e nell’accostamento allo studio della storia italiana ed europea del XIX e del XX secolo – oggetto di un prezioso studio di Federico Mazzei – che occupa gli interessi di quello che era stato l’ultimo segretario del Partito Popolare.
Quell’impegno che appare prima di tutto culturale, si rivelerà in realtà un prezioso strumento di elaborazione di una lucida strategia politica allorché, con la guerra, il crollo del regime fascista, la Resistenza e la nascita della Repubblica, De Gasperi e la Democrazia Cristiana si faranno carico della guida politica del paese. Quella stagione si apre su uno scenario fra i più complessi e problematici non solo per l’Italia, che si ritrova sconfitta, segnata da un costo materiale altissimo e da profonde lacerazioni sul terreno civile e morale. Uno sguardo alla prospettiva europea rivela con chiarezza che le nazioni e gli stati del Vecchio Continente passano la mano sul piano della determinazione delle grandi scelte di politica estera.
La Francia e la Gran Bretagna, pur vincitrici, non hanno più la forza e il ruolo di primato che detenevano prima del 1939, mentre la Germania, oltre che sconfitta, viene considerata come il problema da risolvere per disinnescare futuri conflitti. Eppure, nel 1945/46 perdurano fortissime pulsioni nazionaliste, che ad esempio emergono in Italia in occasione della sofferta ratifica del Trattato di pace, considerato da non poca parte dell’opinione pubblica come inaccettabile e ingiusto, lesivo dei diritti della nazione. Tutto questo avviene mentre l’Europa diviene uno dei teatri dello scontro fra due opposti modelli politici, economici e sociali: quello del socialismo reale a Est e quello americano a Ovest.
La compiuta assunzione di questo stato di cose è alla radice della convinzione, maturata nella coscienza dello statista trentino e condivisa con figure come Konrad Adenauer, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, che l’urgenza di provvedere alla ricostruzione materiale e morale dei paesi europei non potesse risolversi solo entro i confini dei singoli stati. La guerra era stata europea perché europee ne erano state le ragioni, che investivano il livello profondo della civiltà e della coscienza morale.
Occorreva allora dare una risposta che inserisse le politiche ricostruttive dentro un orizzonte nel quale la riedificazione democratica dell’Europa diventava itinerario per l’instaurazione della pace perché metteva al centro delle scelte politiche la dignità della persona, la sua libertà, i doveri di solidarietà sociale, economica e civile che la qualificano. In ragione di tale consapevolezza, la cornice sovranazionale europea non poteva limitarsi ad essere regolata da una serie di trattati; essa richiedeva, piuttosto, un compiuto ordinamento politico, capace di dar vita ad un soggetto in grado di garantire la possibilità di un più compiuto sviluppo dei diritti e dei doveri dei cittadini degli stati europei.
Sono queste le radici politiche che occorre richiamare per capire che cosa spinse uomini di estrazione culturale e politica profondamente diverse, come Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli, a convergere sul progetto della “Comunità Europea di Difesa” (CED), il cui trattato, varato il 27 maggio 1952, venne poi respinto dall’Assemblea Nazionale francese il 30 agosto 1954. Quella iniziativa, che viene spesso ridotta alla proposta della creazione di una forza armata europea, aveva in realtà una prospettiva politica assai più articolata ed era tesa a rendere solide le basi per una compiuta pacificazione dell’Europa.
La CED, infatti, comportava il superamento degli eserciti nazionali dentro la cornice di una guida politica europea, così come si veniva realizzando in quegli stessi anni per la gestione della produzione di carbone e acciaio. Essa richiedeva l’esistenza di un’autorità politica europea, che includeva un’assemblea parlamentare, che sceglieva di operare entro i limiti della Carta delle Nazioni Unite, dunque come fattore di pacificazione. In tal modo, la questione della dimensione militare della politica veniva sottratta ai singoli stati, cioè a quei soggetti che l’avevano utilizzata per politiche di potenza ed egemonia, per essere posta dentro una nozione di difesa assai più ampia che il semplice ricorso alle armi. E questo liberava energie e risorse per le politiche ricostruttive di cui l’Europa necessitava in quegli anni, parendo un orizzonte in cui l’unità politica fra gli stati del Vecchio Continente intendeva essere progetto di pace e di salvaguardia dei valori spirituali e morali fra i popoli europei. Ne fa fede l’inserimento, voluto proprio di De Gasperi, dell’articolo 38 del trattato istitutivo della CED, che prevedeva l’avvio di un processo costituente che usciva dalla logica di una semplice gestione funzionale dei processi decisionali per passare ad un più compiuto approccio politico di carattere democratico.
Alla radice della CED vi era dunque la presa d’atto che la realtà imponeva agli stati europei l’unità politica come concreta e fattiva possibilità per poter tornare ad avere una voce su scala internazionale con cui far valere le ragioni della promozione della persona umana e della pace come sistema fattivo di relazioni internazionali e di farlo perseguendo la pace come obiettivo politico e non certo come status quo da difende con le armi. In un celebre discorso tenuto a Strasburgo il 10 dicembre 1951 De Gasperi spiegava così le ragioni politiche della CED: «Ma la condizione essenziale per una resistenza esterna efficace è in Europa. È in Europa la difesa interna contro una funesta eredità di guerre civili – tali bisogna considerare le guerre europee dal punto di vista della storia universale – questo alternarsi, cioè, di aggressioni e rivincite, di spirito egemonico, di avidità di ricchezza e di spazio, di anarchia e di tirannia che ci ha lasciato la nostra storia, per il resto così gloriosa. È dunque contro questi germi di disgregazione e di declino, di reciproca diffidenza e di decomposizione morale, che noi dobbiamo lottare».
Ne emergeva una visione politica di cui si coglie la distanza rispetto a quanto oggi anima il dibattito pubblico europeo. In De Gasperi era infatti profonda la convinzione che l’unità europea nella difesa fosse una tappa essenziale ma non risolutiva di un processo di costruzione politica che aveva i connotati della democrazia. Era il sogno di quegli “Stati Uniti d’Europa”, che avrebbe potuto edificare una “Patria più grande”, capace di essere non più l’incubatrice di nazionalismi distruttivi ma la culla di popoli che si riconoscono in un comune patrimonio di civiltà maturato nei secoli e praticano la pace come orizzonte dell’agire politico.